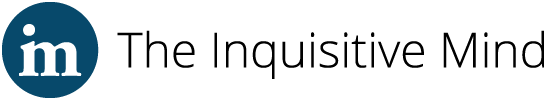Se il Robot è 'Simpatico' e la Stampante 'Capricciosa': Il Fascino dell’Antropomorfismo
Immaginiamo questa situazione: ci rechiamo in ufficio e dobbiamo stampare un documento. Prepariamo la stampa sul nostro PC, inviamo il documento alla stampante, e… la stampante non funziona. Un messaggio sullo schermo ci informa che manca carta nel cassetto 2. Inseriamo la carta, ma ancora niente. Riapriamo il cassetto, ma la macchina non risponde. A quel punto ci rendiamo conto che si è bloccata e che l’unica soluzione è chiedere un aiuto a qualcuno/a più esperto/a di noi. Questa scena ci è probabilmente familiare. E la reazione più comune? Innervosirsi e pronunciare frasi del tipo: “Questa stampante deve avercela con me, la odio, non la sopporto”. Ecco, un perfetto esempio di antropomorfismo. L’antropomorfismo, dal greco άνθρωπος (anthrōpos), "umano" e μορφή (morphē), "forma", è la tendenza ad attribuire caratteristiche, motivazioni, intenzioni ed emozioni umane a tutto ciò che non è umano (Epley et al., 2007; Guthrie, 1993). Il filosofo greco Senofane (VI secolo A.C.) fu il primo a usare il termine “antropomorfismo” descrivendo le somiglianze tra le divinità e i loro devoti. Diverse ricerche empiriche (per approfondire vedere Waytz et al., 2010) hanno dimostrato la facilità con cui le persone danno descrizioni antropomorfe a forme geometriche, animali, oggetti comuni, macchine, o piante. Ad esempio, antropomorfizziamo il nostro cane, che è “felice” di vederci, la nostra automobile, che, se non parte è “arrabbiata”, ma anche le condizioni atmosferiche: “oggi il Sole è proprio pallido”. Recentemente, molti/e studiosi/e in ambito psicosociale stanno cercando di comprendere il perché di questa tendenza così pervasiva e spontanea delle persone. In questo articolo, cercheremo di dare una risposta a questa domanda, attraverso esempi pratici e la descrizione degli studi principali in quest’ambito.
Comprendere l'antropomorfismo: le basi psicologiche dell’umanizzazione
Per capire cosa ci spinge a riconoscere umanità anche in ciò che umano non è, prendiamo anzitutto in esame il lavoro di Epley e colleghi (2007) e quello di Gabriella Airenti (2018). Secondo Epley e colleghi, l’antropomorfismo si manifesta lungo un continuum (vedere Glossario per una definizione) dalle forme più indirette, in cui trattiamo un’entità come se avesse caratteristiche umane senza attribuirgliele realmente, fino a forme più esplicite e dirette, in cui si attribuiscono con convinzione tratti umani a un agente non umano. Nella loro “Teoria a tre fattori sull’antropomorfismo” gli autori propongono un modello composto da tre determinanti psicologiche. La prima ha origini cognitive e si basa sul fatto che per capire qualcosa di nuovo, tendiamo a partire da ciò che conosciamo meglio: noi stessi. Quando vediamo qualcosa di ignoto, per interpretarlo, partiamo da ciò che conosciamo meglio vale a dire noi stessi. Secondo gli autori questo accade prima di tutto per il vincolo fisico. Le persone conoscono bene cosa significa essere umani, ed è su questa esperienza che si basano per capire ciò che non conoscono. Tuttavia, non sanno cosa significa non essere “esseri umani”. In secondo luogo, guardare l'azione di un altro agente umano sembra fornire una base per l’interpretazione del mondo esterno. Questo è in linea con le evidenze dalla ricerca sui neuroni a specchio (Rizzolatti & Craighero, 2004), che si attivano involontariamente quando si esegue un’azione e quando si osserva la stessa azione compiuta da un'altra persona. È noto poi come, a partire dai primi istanti di vita, sia fondamentale per la sopravvivenza il ruolo del caregiver (vedere Glossario): ciò ci spinge a dare rilevanza agli esseri umani intorno a noi e quindi ad avere una rappresentazione mentale precisa di ciò che è l’umanità. È importante poi sottolineare come la capacità di riconoscere ciò che è umano partendo dalla propria esperienza diretta, sia un processo facilitato quando l’agente non umano ci assomiglia nell’aspetto fisico (Johnson, 2003) e nel movimento (Heider, 1944). Questo è particolarmente rilevante, ad esempio, nel caso dei robot umanoidi (vedere Glossario per una definizione). Come approfondiremo successivamente, lo studio dell'interazione umano-robot ha evidenziato come la costruzione di robot con un aspetto che richiama quello umano (ad esempio, dotati di volti e corpo) e che si comportano in modo simile a noi (ad esempio, capaci di comunicare e camminare), faciliti l'accettazione e la comprensione di queste macchine complesse (Sciutti et al., 2018). Ulteriori ricerche confermano il ruolo della rappresentazione cognitiva nel determinare l’antropomorfismo dei robot. L’aspetto umanoide dei robot sembra infatti influenzare i processi cognitivi che regolano l’elaborazione di stimoli sociali. I robot umanoidi attivano un processo di elaborazione cognitiva negli osservatori di tipo configurazionale (vedere Glossario), simile a quello che si elicita quando guardiamo un essere umano (Sacino et al., 2022; Andrighetto et al., 2025).
Epley e colleghi (2007) propongono poi che il meccanismo cognitivo alla base dell’antropomorfismo agisca assieme ad altre due determinanti più strettamente psicologiche: la motivazione all’efficacia e la motivazione alla socialità. La motivazione all’efficacia riguarda il bisogno di spiegare e comprendere l’ambiente circostante in modo da essere efficienti nelle azioni. Applicata all’antropomorfismo, si riferisce alla necessità di interagire in modo efficace con entità non umane. Pensare che un oggetto abbia emozioni o intenzioni umane ci aiuta a spiegarne il comportamento e ad avere l’illusione di poterlo controllare o prevedere come si comporterà nel futuro. L’antropomorfismo aiuta infatti a interpretare il mondo in termini familiari.
Nascondi i commenti degli utenti
Mostra i commenti degli utenti
Autore/i dell'articolo
Articolo in pdf
Newsletter
Keep me updated about new In-Mind articles, blog entries and more.