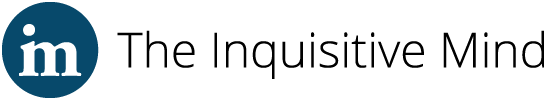Se il Robot è 'Simpatico' e la Stampante 'Capricciosa': Il Fascino dell’Antropomorfismo
Questi esempi dimostrano come nelle culture industrializzate l’antropomorfismo sia una strategia narrativa efficace e diffusa, che aiuta il pubblico a identificarsi con personaggi non umani attraverso caratteristiche tipicamente umane. La letteratura mostra anche come l’antropomorfismo influenzi la percezione dei diritti degli animali (Loughnan et al., 2014; Singer, 1975; Würbel, 2009): il grado di antropomorfismo influisce sulla disposizione, sia degli individui che devi governi, a stanziare dei fondi per la conservazione della biodiversità animale, privilegiando specie morfologicamente più simili agli esseri umani (Martín-Forés et al., 2013; Martín-López et al., 2007). Inoltre, influisce sul rapporto con l’ambiente: Williams et al. (2021) e Tam et al. (2013) evidenziano che attribuire caratteristiche umane alla natura rafforza il senso di connessione con essa, favorendo comportamenti pro-ambientali (Mayer et al., 2009; Nisbet et al., 2011). Sembra che tendiamo a cercare umanità fuori da noi, apprezzando di più ciò che ci circonda. Uno degli effetti dell’antropomorfismo sul nostro comportamento, particolarmente rilevante per il contesto attuale, riguarda le tecnologie avanzate come i robot o l’intelligenza artificiale. L’avvento della robotica ha introdotto nuove entità con cui l’umanità sta imparando a confrontarsi: oggetti inanimati che possiedono caratteristiche tipiche degli esseri viventi. I robot sociali (vedere Glossario), infatti, non sono semplicemente delle entità artificiali come l’aspirapolvere o il frullatore della nostra cucina, ma sono oggetti tecnologici appositamente costruiti per essere in grado di interagire con gli esseri umani. La prospettiva di un futuro dove i robot e l’intelligenza artificiale saranno parte integrante della nostra quotidianità è fortemente legata a riflessioni riguardo la loro antropomorfizzazione e alle conseguenze sul nostro comportamento. I robot, che tradizionalmente sono stati progettati per operare indipendentemente dagli esseri umani, stanno gradualmente iniziando a svolgere compiti sempre più sociali e a lavorare a contatto con le persone nei posti di lavoro e in spazi pubblici (come scuole o ospedali). Il loro utilizzo in ambienti sociali ne ha anche modificato lo sviluppo e il design: i robot tendono ad avere un aspetto umanoide e sono capaci di esprimere un preciso linguaggio del corpo, di interagire e cooperare con chi gli sta intorno (Phillips et al., 2018). L’aspetto dei robot ha una forte influenza sul nostro comportamento: molti studi empirici condotti negli ultimi anni hanno mostrato come l’umanizzazione di un robot influenza la percezione della sua intelligenza, socievolezza ed empatia (Sacino et al., 2022). Più è alto l’antropomorfismo percepito di un robot, più le persone tendono a fidarsi, accettarne i consigli ed empatizzare con esso/a, attribuendogli maggiore umanità (Natarajan et al., 2020). Tuttavia, quando l’aspetto o il comportamento di un robot si avvicina molto a quello umano senza riuscire a riprodurlo perfettamente, può emergere un senso di inquietudine o disagio: è il fenomeno noto come “Uncanny Valley” (Mori et al., 2012) letteralmente “La Valle Inquietante” (vedere Glossario). Secondo questa teoria, esiste una soglia oltre la quale l’aumento dell’umanità percepita provoca una reazione negativa, dovuta alla percezione di qualcosa che appare “quasi umano” ma non del tutto autentico.
Implicazioni dell’antropomorfismo in un futuro sempre più hi-tech
Autore/i dell'articolo
Articolo in pdf
Newsletter
Keep me updated about new In-Mind articles, blog entries and more.