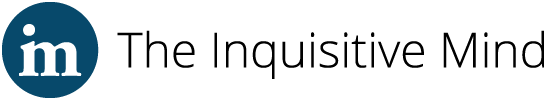Se il Robot è 'Simpatico' e la Stampante 'Capricciosa': Il Fascino dell’Antropomorfismo
Ad esempio, quando il computer si blocca, potremmo dire che "è arrabbiato con noi", attribuendogli un’emozione umana per spiegare il malfunzionamento in modo intuitivo (Morewedge et al., 2007). Infine, la motivazione alla socialità si basa sul desiderio di contatto e affiliazione, elementi essenziali dell’esperienza umana. L’antropomorfismo permette di percepire una connessione simile a quella umana anche con agenti non umani. Questo è particolarmente marcato in condizione di assenza di relazioni sociali. Ne è un esempio emblematico il film Her (2013), in cui il protagonista, dopo un divorzio, per sentirsi meno solo sviluppa un legame affettivo con un sistema operativo. Più a livello sociale, l’attuale tendenza ad antropomorfizzare i nostri animali domestici, attribuendogli caratteristiche ed emozioni spesso unicamente umane, può anche essere ricondotto a una crescente frammentazione delle relazioni sociali con gli altri essere umani, tipica della società odierna.
Oltre a queste tre determinanti principali, il modello di Epley e colleghi (2007) prevede che la propensione ad antropomorfizzare sia influenzata da variabili personali (ad esempio, la Necessità di Elaborazione Cognitiva, vedere glossario) e situazionali. In particolare, è rilevante il tessuto culturale di riferimento: la cultura fornisce, norme e ideologie che regolano le relazioni e il livello di esperienza con alcuni agenti non umani, cambiando in questo modo la conoscenza al riguardo. Pensiamo ad esempio alle culture industrializzate: interagiamo meno con gli animali, soprattutto quelli da allevamento; quindi, ne comprendiamo meno il comportamento e tendiamo ad antropomorfizzarli, attribuendo loro emozioni e intenzioni umane (Ross et al., 2003). Al contrario, nelle culture rurali, la conoscenza diretta degli animali riduce questa tendenza, mentre la minore familiarità con la tecnologia porta ad antropomorfizzare maggiormente gli strumenti tecnologici per renderli più comprensibili (Medin & Atran, 2004). La struttura tripartita del modello teorico di Epley e colleghi, permette di spiegare la variabilità dell’antropomorfismo, aiutandoci a comprendere non solo perché attribuiamo tratti umani a ciò che non lo è, ma anche come e in quali circostanze e con quale intensità questo processo avviene. Parzialmente in contrasto con il modello descritto, Gabriella Airenti (2018) descrive il processo di antropomorfismo come fondato su un’interazione specifica in cui un agente non umano viene trattato come un interlocutore all’interno di uno scambio comunicativo. Al centro di questa visione vi è l’idea che antropomorfizzare significhi instaurare un dialogo immaginario con un’entità non umana, portando così all’attribuzione di intenzionalità, di comportamenti sociali, di stati cognitivi e affettivi. Questo processo implica l’attivazione di una forma di Teoria della Mente (Frith & Frith, 2005), ovvero la capacità di attribuire stati mentali ad altri agenti (si veda il Glossario). Airenti rifiuta l’idea che l’antropomorfismo dipenda dal livello di somiglianza con l’umano o dall’incertezza sulla natura dell’agente antropomorfizzato, proponendo che l’antropomorfismo sia esclusivamente una modalità relazionale, funzionale agli obiettivi dell’individuo. Se dobbiamo aprire una porta ma questa fa resistenza, malediciamo la porta come se questa resistesse intenzionalmente ai nostri tentativi di aprirla. In altre parole, non si tratta di una credenza stabile, ma di un “semplice” processo comunicativo che può essere attivato o sospeso a seconda del contesto. Anche in situazioni di minaccia, come un temporale o un incendio (“le fiamme stanno divorando tutto senza pietà”), ciò che viene antropomorfizzato non è l’evento in sé, ma il tipo di relazione che la persona stabilisce con esso. Nonostante questa differente concettualizzazione, la teoria di Airenti resta compatibile con l’idea che esistano differenze individuali nell’antropomorfismo. Ad esempio, individui con una minore rete di connessioni sociali possono essere più propensi a instaurare relazioni immaginarie con entità non umane, in linea con quanto sostenuto anche dal modello di Epley e colleghi.
Gli effetti dell’antropomorfismo sul nostro comportamento: dall’intrattenimento alla tecnologia
La tendenza ad antropomorfizzare nella vita quotidiana può essere incoraggiata al fine di orientare o promuovere nostri comportamenti. Ne sono un esempio le strategie di marketing e quelle di intrattenimento. Troviamo spesso negli spot televisivi bottiglie d’acqua dall’aria umanoide, cibo con tratti come occhi, bocche e così via. Come mai è così presente l’umanizzazione (i.e., sinonimo di antropomorfismo, vedere Glossario) in questo campo? Rendere prodotti o personaggi morfologicamente più simili a noi, aiuta a suscitare le emozioni desiderate e trasmette un senso di relazione sociale che facilita la vendita del prodotto. L’antropomorfizzazione è centrale poi nei film d’animazione: la Walt Disney Company è forse l’esempio più iconico. Fin dai suoi esordi, la Disney ha trasformato animali in personaggi umanizzati, dotandoli di emozioni, pensieri e comportamenti propri degli esseri umani. Da Topolino, Pippo e Paperino fino al più recente Zootropolis (2016), il mondo animale è stato spesso rappresentato come specchio della società umana. A questo proposito, è impossibile non pensare anche ad altre case cinematografiche come la Pixar, che hanno ampliato il concetto di antropomorfismo per scopi narrativi e di intrattenimento. Non solo animali, ma anche oggetti e concetti astratti sono stati umanizzati: dalle automobili di Cars – Motori Ruggenti (2006) alle emozioni stesse in Inside Out (2015).