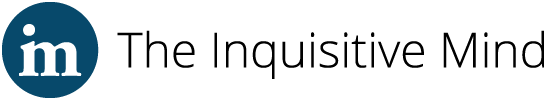La realtà virtuale come strumento di comprensione delle diverse identità di genere
La realtà virtuale come strumento di e comprensione delle diverse identità di genere
Gli ambienti digitali hanno conosciuto negli ultimi anni un’evoluzione significativa, che ha trasformato le modalità con cui gli utenti esprimono la propria identità. Se in passato questa si manifestava principalmente attraverso nickname o immagini del profilo, oggi passa sempre più spesso attraverso avatar personalizzabili. L’integrazione di avatar tridimensionali e la possibilità di accedere al metaverso (si veda il glossario) attraverso dispositivi di realtà virtuale (Virtual Reality; VR) ha ridefinito l’interazione digitale: il corpo fisico dell’utente diventa la vera interfaccia tra una persona e lo spazio virtuale e tra gli individui, superando l’uso dei tradizionali strumenti di input come tastiere, mouse o joystick. Il legame con il proprio avatar non è solo funzionale, ma rappresenta qualcosa di profondamente psicologico. Le persone, infatti, non si limitano a “trasferirsi” in uno spazio virtuale: vi portano anche la propria storia e le esperienze socioculturali che le caratterizzano (Murray & Sixsmith, 1999). Questo suggerisce l’esistenza di una connessione intima tra il corpo fisico dell’utente e il suo corpo virtuale, l’avatar. Come osservano Yee e Bailenson (2007, p. 274), “l’avatar non è semplicemente un’uniforme che si indossa, ma è l’intera rappresentazione di noi stessi […], è l’indizio principale della nostra identità negli ambienti online.” In questo scenario, gli ambienti virtuali non rappresentano solo spazi di interazione sociale, ma anche laboratori per esplorare e sperimentare l’identità personale. In particolare, le tecnologie immersive offrono nuove possibilità per riflettere e agire sulla propria identità di genere, consentendo agli utenti di incarnare avatar che si discostano dalle caratteristiche del corpo biologico e aderiscono invece a dimensioni identitarie sentite, ma talvolta non ancora espresse nel mondo reale. Questa possibilità di vivere in prima persona esperienze corporee e relazionali attraverso un corpo digitale diverso dal proprio corpo fisico può favorire la comprensione e la consapevolezza di sé, ma anche contribuire a ridurre stereotipi e pregiudizi nei confronti, ad esempio, di persone transgender e di genere non conforme, facendo strada a nuove prospettive di inclusione sociale e trasformazione culturale.
I meccanismi cognitivi alla base dell’esperienza virtuale e del legame con l’avatar
L’esperienza immersiva offerta dalla realtà virtuale non è il semplice risultato dell’uso di tecnologie avanzate, ma è resa possibile da specifici meccanismi cognitivi che permettono agli individui di percepire il corpo virtuale come parte integrante del proprio Sé. Questo fenomeno, noto come embodiment, costituisce una delle chiavi interpretative fondamentali per comprendere come gli utenti si relazionino psicologicamente al proprio avatar, ovvero alla propria rappresentazione digitale in un ambiente virtuale o di gioco. Gli avatar ricoprono un ruolo significativo nella maggior parte dei mondi virtuali. In questo senso, un avatar rappresenta il sé fisico di un utente in un ambiente digitale accrescendo anche la possibilità di manipolazione e personalizzazione di tale aspetto del sé (Duchenaut et al., 2009; Schroeder, 2012). L’embodiment non si limita a una sensazione soggettiva generica di “essere nel virtuale”, ma si articola in tre componenti fondamentali: il senso di agency, la self-location e il body ownership (per una definizione, si veda il glossario). In realtà virtuale, questi principi vengono estesi al corpo intero, grazie alla possibilità di sincronizzare i movimenti reali dell’utente con quelli dell’avatar, generando un’esperienza altamente realistica e immersiva in cui l’avatar viene percepito non solo come una rappresentazione simbolica, ma come un’estensione corporea del Sé. La forza di questo senso di embodiment non solo aumenta il coinvolgimento emotivo, ma rende l’esperienza virtuale profondamente personale, aprendo spazi per un’esplorazione identitaria che va ben oltre la semplice interazione tecnica con un ambiente digitale.
I meccanismi psicologici legati all’interazione con l’avatar: il Proteus Effect
Oltre a queste componenti percettive e corporee, l’interazione con il proprio avatar attiva processi psicologici più complessi che vanno a modellare comportamenti, atteggiamenti e persino la percezione del proprio Sé. Uno dei fenomeni più rilevanti in questo ambito è il cosiddetto Proteus Effect (Yee & Bailenson, 2007), ovvero la tendenza degli utenti a conformarsi a tratti e stereotipi associati all’aspetto del proprio avatar. In altre parole, non è solo l’utente a influenzare il proprio avatar, ma l’avatar, a sua volta, modella l’utente. Nei loro studi pionieristici, Yee e Bailenson hanno dimostrato che gli individui che incarnano avatar fisicamente attraenti o più alti tendono a comportarsi in modo più assertivo, sicuro e socievole, mentre chi utilizza avatar meno attraenti o di statura inferiore tende a mantenere un comportamento più ritirato o accondiscendente. Questi effetti emergono rapidamente, anche in contesti privi di feedback sociale esplicito, suggerendo che l’apparenza dell’avatar agisce come un indizio identitario che l’utente interiorizza inconsciamente, modificando il proprio comportamento in modo coerente con le aspettative evocate da quella forma corporea.
Nascondi i commenti degli utenti
Mostra i commenti degli utenti
Autore/i dell'articolo
Parole chiave dell'articolo
Articolo in pdf
Newsletter
Keep me updated about new In-Mind articles, blog entries and more.