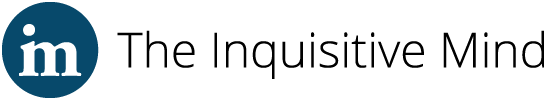La realtà virtuale come strumento di comprensione delle diverse identità di genere
Il Proteus Effect non si limita agli aspetti sociali più superficiali, ma ha dimostrato di avere impatti più profondi sul modo in cui le persone percepiscono sé stesse e gli altri. Il fenomeno ha implicazioni rilevanti in ambito educativo, terapeutico e sociale, ed è stato osservato anche in relazione al genere e all’empatia intergruppi (Fox et al., 2013; Peña et al., 2009). Inoltre, la possibilità di personalizzare l’avatar – di scegliere un corpo che rifletta non solo l’aspetto desiderato, ma anche aspetti identitari profondi – favorisce un maggiore livello di immedesimazione e rende più probabile l’attivazione di questo effetto psicologico (Ratan & Dawson, 2016; Li & Lwin, 2016). Le persone tendono ad interiorizzare tratti associati al proprio avatar, con effetti che possono persistere anche nel mondo reale. Infatti, in alcuni casi, il cambiamento comportamentale non resta confinato al contesto virtuale, ma si estende anche al mondo fisico: studi recenti suggeriscono che gli effetti indotti dal Proteus Effect possono persistere nel tempo, influenzando atteggiamenti e scelte anche dopo la fine dell’esperienza immersiva. Ad esempio, in uno studio di Yee e colleghi (2009), i partecipanti sono stati collocati in un ambiente virtuale immersivo utilizzando avatar più bassi o più alti in base alla condizione. Oltre a rilevare una differenza comportamentale all'interno dell'ambiente virtuale, gli autori hanno riscontrato che i partecipanti a cui sono stati assegnati avatar più alti hanno negoziato in modo più aggressivo nelle successive interazioni faccia a faccia rispetto ai partecipanti a cui sono stati assegnati avatar più bassi. Un altro studio (Peña et al., 2009) ha evidenziato come gli avatar dotati di connotazioni negative possano influenzare la cognizione degli utenti in modo coerente con le associazioni evocate dal loro aspetto. In particolare, i partecipanti che utilizzavano avatar con un mantello nero — colore comunemente associato a caratteristiche stereotipate come “malvagità” e “aggressività” (Frank & Gilovich, 1988) — hanno mostrato intenzioni e atteggiamenti significativamente più aggressivi rispetto a quelli che utilizzavano avatar con un mantello bianco. Inoltre, chi indossava l’avatar nero ha riportato livelli significativamente più bassi di coesione di gruppo rispetto ai partecipanti assegnati all’avatar con mantello bianco. Questi risultati suggeriscono che anche caratteristiche visive apparentemente semplici degli avatar possono influenzare in modo sostanziale i processi cognitivi e sociali degli utenti. Questo fenomeno rende l’avatar un potente mediatore psicologico, capace di fungere da leva per il cambiamento personale e sociale. Alla luce di queste evidenze, è plausibile affermare che la realtà virtuale non sia solo una tecnologia immersiva, ma uno strumento che può generare effetti profondi sulla costruzione del Sé e sulla relazione con gli altri. Proprio per questo, i meccanismi cognitivi e psicologici attivati dall’embodiment e dall’interazione attraverso un avatar aprono scenari di grande interesse per la ricerca e per la costruzione di interventi psico-educativi.
Esplorare il Sé e l’identità di genere attraverso l’avatar
Autore/i dell'articolo
Parole chiave dell'articolo
Articolo in pdf
Newsletter
Keep me updated about new In-Mind articles, blog entries and more.