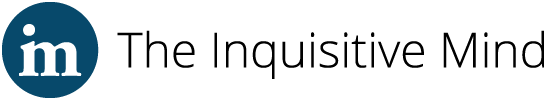Bambini e bambine davanti a uno schermo: qual è l’impatto della tecnologia sul loro sviluppo?
La famiglia è il primo ambiente di crescita nel quale si instaura la relazione educativa, affettiva e comunicativa tra l’adulto/a e i/le bambini/e. Il contesto familiare è quello prevalente, specialmente nei primi 1000 giorni di vita. Oggi, la presenza della tecnologia sta ponendo nuove sfide alle relazioni familiari e, spesso, rischia di sostituire le figure genitoriali (Genta, 2021). Per questo, già a partire dal 2013, l’Accademia Americana di Pediatria ha fornito le prime raccomandazioni per un uso consapevole e ponderato dei device. Queste raccomandazioni sono state successivamente condivise anche dalla SIP (2018) e ampliate dalla World Health Organization (WHO, 2019) che, contestualmente, ha offerto anche strategie di promozione dell’attività fisica per contrastare un ulteriore effetto degli strumenti digitali, noto come sedentary screen time. In sostanza, per i bambini e le bambine al di sotto dei 2 anni è vivamente sconsigliato l’uso dei touchscreen, specialmente durante i pasti, un’ora prima di andare a dormire e/o per calmarli. tra i 2 e i 5 anni il limite dell’esposizione è di massimo un’ora al giorno e massimo di due tra i 5 e gli 8 anni. In merito alla durata dell’esposizione, sono interessanti l’approccio graduale di Tisseron (2016) con la regola 3-6-9-12, anche noto come dieta digitale, e il metodo proposto da Shapiro (2019). Secondo Tisseron, così come si rispettano le tappe di sviluppo dei/lle bambini/e in relazione alla propria crescita o, ad esempio, all’entrata nel mondo della scuola (a 3 anni la scuola dell'infanzia; a 6 anni la primaria; a 9 anni l'apprendimento completo della lettura-scrittura; a 11-12 anni la scuola secondaria) o, ancora, alle regole alimentari (con l’introduzione di cibi adeguati in base all’età), così il genitore dovrebbe impostare le direttive per avvicinare progressivamente i/le bambini/e alle tecnologie. Nello specifico, l’autore suggerisce questo approccio: prima dei 3 anni bisogna evitare i dispositivi tecnologici specialmente per il gioco, prima dei 6 non dare nessun tablet personale al bambino. Ancora, lo studioso consiglia internet dopo i 9 anni e i social network dopo i 12. Anche il metodo ideato da Shapiro (2019) può essere un buon alleato per guidare il genitore. In sostanza, l’autore afferma che lo strumento digitale deve diventare per il genitore e i/le bambini/e un mezzo di socializzazione familiare che, specialmente per i più piccoli, non deve essere usato durante i pasti. I/le bambini/e devono essere messi/e nella condizione di conoscere i dispositivi tecnologici che usano passando prima, però, per esperienze “tradizionali” come, ad esempio, quella del gioco, perché in questo modo è possibile sviluppare un reale approccio empatico. Se queste indicazioni vengono seguite correttamente riducono i rischi di assuefazione da parte dei/lle più piccoli/e (Johnson, 2020) e prevengono quelli della dipendenza digitale che potrebbero presentarsi in età adolescenziale. Una fruizione sicura e controllata viene garantita dalla presenza del genitore che condividendo il tempo con il/la bambino/a può stimolare il dialogo e una costruzione narrativa dell’esperienza. Il tempo che il/la bambino/a spende sugli schermi è spesso sottratto all’esplorazione del gioco semplice (Serra, 2012) e simbolico. Il gioco simbolico è un'attività fondamentale per lo sviluppo cerebrale dei/lle bambini/e perché il loro cervello è predisposto naturalmente al gioco (Harding, 2023) e quello virtuale potrebbe compromettere questa competenza simbolica, che compare a partire dai 2 anni, quando dimostrano la capacità di richiamare alla mente qualcosa che sta per qualcos’altro (Bonino, 2018). Questa capacità si favorisce se i/le più piccoli/e possono maneggiare, ad esempio, libri di carta, perché questo aiuta loro a trasferire le informazioni del testo ai contesti reali, comprendendo così la doppia natura delle immagini (DeLoache, 1989). Oltre a quanto sopra messo in evidenza, i genitori devono essere consapevoli che un uso eccessivo e incontrollato della tecnologia disorienta i/le bambini/e sul piano della realtà-virtualità e potrebbe esporli/e al pericolo virtuale, come il cyberbullismo. Infatti, secondo i dati del report Moige (2023) il 31% di minori è vittima di almeno un episodio nella vita. Secondo l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE, 2021), la navigazione online, espone i bambini e le bambine a quattro macrocategorie di rischio: contenuto, cioè i casi in cui il/la bambino/a si espone a contenuti disponibili anche a tutti gli altri utenti della Rete senza limiti d’età; condotta, cioè quando i bambini e le bambine sono protagonisti in uno scambio tra pari e tengono un comportamento non idoneo; contatto, cioè quando un/una bambino/a possono essere vittime di una situazione dannosa in Rete, e infine consumatori/trici, cioè quello che potrebbe celarsi dietro le app per acquisti. All’interno della categoria rischi di contenuto rientrano l’incitamento all’odio (a esempio immagini, parole, che possono prendere di mira un certo tipo di religione, genere, etc..) quelli nocivi (truffe online, pubblicità pornografiche), quelli illegali (violazione delle leggi e norme sociali) e quelli di disinformazione (fake news). I comportamenti che mettono a rischio la condotta dei/lle bambini/e sono invece i comportamenti di odio, i comportamenti dannosi, illeciti e problematici come a esempio scambio di messaggi o immagini sessuali. Invece, le situazioni di contatto in rete che mettono a rischio fanno riferimento a comportamenti come il cyberbullismo (bullismo attuato tramite l’uso di dispositivi digitali), il sexting (invio di messaggi/immagini sessuali) e la sextortion (estorsione sessuale). In ultimo, i rischi riguardanti la privacy, la salute e il benessere rientrano in quella categoria che è stata precedentemente definita ‘rischio per i/le consumatori/trici.
Nascondi i commenti degli utenti
Mostra i commenti degli utenti
Autore/i dell'articolo
Articolo in pdf
Newsletter
Keep me updated about new In-Mind articles, blog entries and more.