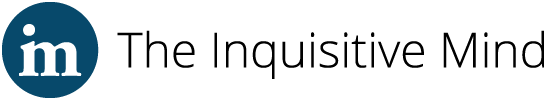Prevenzione e politiche pubbliche: costruire la resilienza alla prossima pandemia
Quando la crisi sanitaria da COVID-19 iniziò a diffondersi nel mondo, Richard Horton, direttore di The Lancet, suggerì che la portata del fenomeno non potesse essere compresa appieno se definita semplicemente come pandemia. Parlò invece di sindemia, evidenziando l’interazione fra l’infezione da SARS-CoV-2 e le condizioni croniche preesistenti, radicate in disuguaglianze sociali e ambientali profonde (Horton, 2020). Questa prospettiva mise in luce un aspetto chiave: il virus non si è diffuso in una popolazione sana ma in società già segnate da fragilità sanitarie e sociali.
Oggi, a distanza di alcuni anni, il concetto di sindemia resta utile come cornice interpretativa, ma la lezione più rilevante riguarda la necessità di rafforzare la prevenzione e la resilienza del Paese per non arrivare impreparati alla prossima pandemia. Durante la COVID-19, molti governi hanno reagito con misure emergenziali, dal contenimento del contagio al potenziamento delle terapie intensive, senza però investire a sufficienza nella salute pubblica e nei determinanti strutturali del benessere collettivo. La gestione delle pandemie future richiederà un approccio integrato in cui le politiche sanitarie, sociali e ambientali superino la logica reattiva per costruire sistemi di prevenzione stabili e intersettoriali. Le evidenze più recenti mostrano inoltre che le strategie di salute pubblica devono promuovere stili di vita salutari come parte integrante della prevenzione (De Vogli, 2024) creando condizioni che rendano possibile e sostenibile per i cittadini adottare comportamenti sani.
Le evidenze accumulate negli ultimi anni mostrano che gli stili di vita hanno avuto un ruolo decisivo nel determinare sia la vulnerabilità all’infezione sia la gravità degli esiti clinici. Una dieta squilibrata, la sedentarietà, il consumo di alcol e tabacco e lo stress cronico sono stati associati a un rischio maggiore di ospedalizzazione e mortalità mentre stili di vita sani basati su attività fisica regolare, alimentazione equilibrata e sonno adeguato, hanno mostrato un effetto protettivo anche nei confronti delle forme gravi di COVID-19, contribuendo a mitigare gli impatti a lungo termine e migliorare la preparazione alle future pandemie (Wang et al., 2024). Queste evidenze confermano che la prevenzione non può limitarsi alla sfera individuale: richiede ambienti sociali e politici che rendano possibile e sostenibile adottare scelte di vita salutari.
Il World Report on Social Determinants of Health Equity 2025 dell’Organizzazione Mondiale della Sanità sottolinea come il benessere e la longevità di una popolazione dipendano in larga misura da fattori sociali, economici e ambientali più che da variabili biologiche (World Health Organization, 2025). Le politiche che si limitano a rafforzano il sistema clinico senza intervenire su istruzione, povertà, lavoro, ambiente urbano e accesso ad una sana alimentazione, risultano quindi parziali e inefficaci. Per rendere le società più resilienti, occorre ripensare la prevenzione come investimento pubblico e collettivo, non come responsabilità del singolo, rafforzando così il capitale sociale di un Paese e la sua sicurezza collettiva e riducendo la vulnerabilità non solo sanitaria ma anche economica e ambientale.
Le città e gli ambienti in cui viviamo possono diventare alleati della salute pubblica se progettati per favorire attività fisica, socialità e accesso equo ai servizi. Spazi verdi, trasporti sostenibili, accesso ad una sana alimentazione e istruzione di qualità rappresentano vere e proprie infrastrutture di salute e prevenzione. Le politiche pubbliche possono inoltre promuovere programmi comunitari di educazione alla salute, campagne informative mirate e incentivi economici per favorire l’adozione di comportamenti salutari. Interventi integrati a livello locale e nazionale di questo tipo contribuiscono a ridurre le disuguaglianze e a rafforzare la resilienza della popolazione (Seraphim et al., 2025), aumentando la capacità delle comunità di fronteggiare emergenze sanitarie future.
Le politiche di resilienza dovrebbero quindi fondarsi su tre pilastri chiave: prevenzione strutturale per ridurre le disuguaglianze prima che diventino emergenze; integrazione intersettoriale per collegare sanità, istruzione e ambiente in una strategia comune di benessere collettivo; e responsabilità politica a lungo termine, che riconosca nella salute un diritto e una forma di giustizia sociale.
La pandemia ha mostrato che la salute pubblica non si difende solo negli ospedali ma nella quotidianità delle scelte, dei luoghi e delle opportunità. Costruire società più sane e resilienti significa investire nella prevenzione e nell’equità: è questa la condizione essenziale per non farsi trovare impreparati di fronte alla prossima crisi globale.
Bibliografia
De Vogli, R. (2024). Managing and Preventing Pandemics: Lessons From COVID-19 (1st Edition). Routledge.
Horton, R. (2020). Offline: COVID-19 is not a pandemic. The Lancet, 396(10255), 874. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)32000-6
Seraphim, A. P., Niu, H., Morgado, P., Miranda, B., & Silva, E. A. (2025). Mapping urban health policies: A scoping review of environmental, behavioural and socioeconomic determinants of health. Progress in Planning, 193, 100926. https://doi.org/10.1016/j.progress.2024.100926
Wang, Y., Su, B., Alcalde-Herraiz, M., Barclay, N. L., Tian, Y., Li, C., Wareham, N. J., Paredes, R., Xie, J., & Prieto-Alhambra, D. (2024). Modifiable lifestyle factors and the risk of post-COVID-19 multisystem sequelae, hospitalization, and death. Nature Communications, 15(1), 6363. https://doi.org/10.1038/s41467-024-50495-7
World Health Organization. (2025). World report on social determinants of health equity. https://www.who.int/publications/i/item/9789240107588
Nascondi i commenti degli utenti
Mostra i commenti degli utenti
Autore/i dell'articolo
Blog Kategorien
- Aggressività (12)
- Benessere (1)
- Complottismo (1)
- Covid-19 (16)
- Deumanizzazione (7)
- Disuguaglianza (10)
- Identità (19)
- Omofobia (3)
- pandemia (16)
- Perdono (1)
- Pride (2)
- Psicoterapia (1)
- Salute mentale (1)
- Sincronia (2)
- Violenza (3)
Post popolari del blog
Nuvola di keyword
agency cambiamento sociale cognizione cognizione sociale contatto intergruppi deumanizzazione editoriale infraumanizzazione Mindfulness pregiudizio relazioni interpersonali sessualizzazioneNewsletter
Keep me updated about new In-Mind articles, blog entries and more.