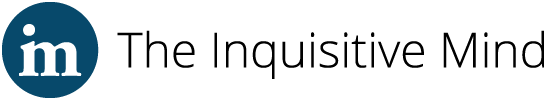L’animale d’allevamento. Kenzaburō Ōe e la deumanizzazione del nemico
L’animalizzazione è la strategia più frequentemente impiegata nel corso della storia per situare l’altro a un livello inferiore. L’animale ha sempre costituito un termine di riferimento importante per la definizione dell’identità umana, perché proprio il confronto con le altre specie ha permesso alla nostra di sancire la propria superiorità su tutti i viventi. Nel corso di questo processo, la riflessione filosofica ha confinato gli animali in tre categorie, caratterizzate dalla volontà di asservimento, dalla paura della bestialità, dal timore del mescolamento e della perdita di specificità. La prima categoria raggruppa gli animali domestici, la seconda le fiere selvagge, la terza i mostri e gli animali immaginati. I gruppi sociali esclusi dalla pienezza dell’umano – le donne, i barbari, il nemico – sono stati assegnati a uno degli insiemi citati e sottoposti a trattamenti diversificati sulla base della pericolosità loro attribuita. In alcuni casi, sono stati quindi associati ad animali domestici, oggetto di paternalismo e sfruttamento; in altri a bestie selvagge, oggetto di disprezzo e cacce; in altri ancora a mostri, oggetto di persecuzioni ed eccidi [1]. L’animalizzazione si è così strettamente intrecciata alla cultura e alla storia occidentali, basti pensare alla definizione di barbaro coniata dal mondo classico, o a quella di homuncoli, usata per i nativi durante la conquista del Nuovo Mondo; esempi di animalizzazione si trovano però in quasi tutte le culture, segnali e simboli di volontà di sopraffazione e legittimazione della violenza. La deumanizzazione animalistica nega a chi la subisce il possesso dei tratti “unicamente umani”: i target sono giudicati incolti, immaturi, irrazionali, incapaci di autocontrollo e di moralità. Essa suscita in coloro che ne sono colpiti emozioni di degradazione e umiliazione e in chi la pratica sentimenti di disgusto e disprezzo, collegati alla percezione della propria superiorità e dell’altrui inferiorità. Si tratta di una forma di deumanizzazione presente soprattutto nei contesti intergruppi, collegata a confronti di tipo asimmetrico [2]. In letteratura le descrizioni di atteggiamenti e comportamenti deumanizzanti che ricorrono al registro animalistico sono infinite. Una, a mio avviso magistrale, costituisce il perno del racconto L’animale d’allevamento, firmato nel 1958 di Kenzaburō Ōe, scrittore giapponese, insignito del premio Nobel per la letteratura nel 1994. Di probabile ispirazione autobiografica – l’autore è nato nel 1935 in una vallata situata al centro dell’isola di Shikoku – il testo, lungo una quarantina di pagine, immerge il lettore nella semplice e povera esistenza di un villaggio giapponese durante un’estate della seconda guerra mondiale. La voce narrante è quella di un adolescente, che vive nel villaggio circondato dal fratello, dalla famiglia e da alcuni compagni. Un giorno la vita dei ragazzi e dell’intera comunità viene sconvolta dalla caduta di un aereo e dalla conseguente cattura di un soldato nemico. Il soldato, la preda, come viene subito chiamato, ha caratteristiche che lo rendono un target ideale di deumanizzazione animalistica:
“Un nemico? Lo chiami nemico” mi gridò Labbroleporino con voce roca, spruzzandomi il viso di saliva e afferrandomi per il petto. “E’ un negro, non un nemico!”
La narrazione è punteggiata da passi che descrivono il prigioniero come un animale e mettono in luce le emozioni – sorpresa, eccitazione, paura – a tale percezione connesse:
“Finché non sapremo che cosa ne pensano in città, lo alleveremo”
“Allevare?”, chiesi stupito. “Allevare come un animale?”
“Sembra davvero un animale!”, disse mio padre seriamente “Puzza come un bue!” (…)”
E come un animale il prigioniero viene trattato:
“Là, illuminata dai fiochi raggi di una lampadina elettrica, era accovacciata la “preda”. La grossa catena della trappola per cinghiali, che legava a un pilastro le sue nere caviglie, attirò con forza il mio sguardo.”
A poco, a poco l’intero villaggio comincia ad abituarsi alla presenza del prigioniero, percepito “come un animale obbediente, tranquillo, mite.”
La degradazione della “preda” è facilitata dalla cultura intessuta di un razzismo quotidiano, scontato, acquisito da secoli, che vede nel colore della pelle un segno di incapacità, debolezza, inferiorità:
“Per noi il soldato negro era come un raro e splendido animale domestico, un animale di talento.”
“Non potevamo credere che quel negro, simile a un animale domestico, una volta era stato un soldato che combatteva la guerra; ci rifiutammo di immaginarlo.”
In un altro punto:
“Il soldato negro, come un lento nero animale, gli occhi sempre bagnati di un liquido denso che poteva essere muco o lacrime, sedeva silenzioso sul pavimento del sotterraneo con le braccia raccolte intorno alle ginocchia: che cosa ci poteva fare di male una volta tolta la trappola? Era poi soltanto un negro!”
Con il passare dei giorni, il rapporto tra il prigioniero e i suoi carcerieri evolve però dall’assoluta estraneità a scambi, dapprima semplici, poi più complessi:
“Il soldato negro comunicava con noi, il soldato negro comunicava come un animale domestico.”
La comunicazione non muta la definizione dell’estraneo, che continua a essere percepito come un animale domestico, accettato nel cerchio di prossimità del villaggio. A poco a poco di verifica però un avvicinamento, inizia un percorso verso una possibile umanizzazione, innescata da un atto di perizia artigianale del soldato, che ripara la cerniera della trappola che si era rotta. “E’ come una persona” nota a un certo punto Labbroleporino, il compagno del narratore e i ragazzi, sedutisi accanto a lui, scoprono “con sorpresa che anche il soldato negro sapeva ridere. Capimmo allora che eravamo legati a lui da un vincolo inaspettato, profondo e saldo, quasi ‘umano’.” La possibilità di una relazione positiva si interrompe però bruscamente appena il soldato capisce che sta per essere portato via dal villaggio e avviato in città verso un destino che intuisce senza speranza. La sua ribellione improvvisa, inaspettata, violenta, sancisce la trasformazione del pacifico animale domestico, che stava lentamente acquistando gradi di umanità, “in una bestia feroce e incapace di capire, in una sostanza pericolosa e velenosa.” E la vicenda precipita verso una fine tragica e crudele, a conferma che l’animalizzazione prelude a esiti nefasti perché non permette le condizioni di parità e reciprocità che sole costituiscono la base per rapporti umani positivi.
Bibliografia
[1] Le Bras-Chopard, A. (2000). Le zoo des philosophes. De la bestialisation à l’exclusion. Paris : Plon.
[2] Sulla deumanizzazione, si veda di Chiara Volpato (2011) Deumanizzazione. Come si legittima la violenza. Roma-Bari: Laterza. Si veda anche il numero speciale della rivista Minority Reports. Cultural Disability Studies, 10, 1, 2020, intitolato Deumanizzazione, in particolare il saggio di Flavia Albarello, “Sono delle bestie!”: L’animalizzazione come strumento per svilire l’umanità altrui.
[3] Il racconto è uno dei quattro che compongono il volume di Kenzaburō Ōe, Insegnaci a superare la nostra pazzia, pubblicato da Garzanti nel 1992.
Autore/i dell'articolo
Blog Kategorien
- Aggressività (12)
- Benessere (1)
- Complottismo (1)
- Covid-19 (16)
- Deumanizzazione (7)
- Disuguaglianza (10)
- Identità (19)
- Omofobia (3)
- pandemia (16)
- Perdono (1)
- Pride (2)
- Psicoterapia (1)
- Salute mentale (1)
- Sincronia (2)
- Violenza (3)
Post popolari del blog
Nuvola di keyword
agency cambiamento sociale cognizione cognizione sociale contatto intergruppi deumanizzazione editoriale infraumanizzazione Mindfulness pregiudizio relazioni interpersonali sessualizzazioneNewsletter
Keep me updated about new In-Mind articles, blog entries and more.