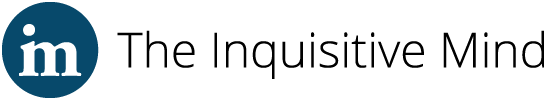La vita accanto. Fare i conti con lo sguardo oggettivante
Una decina di anni fa ho letto tutto d’un fiato La vita accanto [1]. L’ho riletto ora perché si annuncia per la primavera del 2024 un film, per la regia di Marco Tullio Giordana. Il romanzo racconta la storia di Rebecca, una bambina segnata da un’irreparabile bruttezza, che rende difficile il suo vivere e aspro il suo percorso esistenziale. Una storia in controtendenza nell’Italia contemporanea, che continua a giudicare le donne per l’aspetto esteriore. In un panorama dominato dall’esibizione di corpi e visi levigati, così simili da apparirci senz’anima, Mariapia Veladiano dà voce a un’esistenza appartata, che fin dalle prime pagine riconosciamo come una figura della nostra quotidianità, che ci affianca all’imbrunire mentre percorre furtiva strade solitarie, con il volto nascosto e il passo affrettato. Rebecca è una di noi, un po’ più sfortunata e sola; come lei ci sentiamo nei momenti in cui più forte si fa la nostra inadeguatezza, quei momenti in cui l’incapacità di competere con i modelli rutilanti esibiti dai media è più insistente e preme il desiderio di fuga. Eppure Rebecca non soccombe di fronte al difficilissimo compito di cercare la propria strada nel mondo; nonostante l’aspetto ripugnante, riesce a resistere all’angoscia e a dare senso alla propria vita. Accanto a Rebecca il libro narra altre figure femminili impegnate a sopravvivere in un universo in cui è impossibile sfuggire al dolore. Non tutte vi riescono, ma tutte sono a loro modo capaci di segnali di attenzione e amore, tutte sanno costruire solidi rapporti di solidarietà, affetto, amicizia. Uno dei motivi per cui il romanzo mi è piaciuto è che non è banalmente consolatorio, non prevede un lieto fine rassicurante; ci parla di una resistenza quotidiana, fatta di piccoli gesti che presuppongono costanza e forza d’animo. La vita accanto un libro importante proprio perché racconta la vicenda di una donna, che affronta un cammino particolarmente accidentato con dignità e coraggio. Un libro che può accompagnarci nelle lotte di questi giorni, che può diventare un segnale distintivo di chi sa andare oltre le apparenze, per cogliere la sostanza nel nucleo profondo delle persone e delle relazioni. Un libro che ci ricorda, in modo sottile, come la biodiversità vada salvaguardata anche tra gli umani, contrastando la deriva che ci vuole tutti copie conformi di un modello di bellezza stereotipato, nel quale ogni originalità diventa difetto. Intorno a Rebecca c’è una città di provincia, Vicenza, con molte ombre e poche luci. Mariapia Veladiano ne descrive con efficacia il clima, dominato da un’ipocrisia sottile, sorridente, apparentemente benevola. Vicenza è un emblema della provincia italiana, costellata da centri storici che sono stati per secoli bellezze mondiali e sono oggi deturpati dalle auto che riconquistano i pochi spazi perduti; sono centri governati da amministrazioni che, indipendentemente dal colore politico, vedono una mission nella sostituzione di alberi secolari con trionfanti rotatorie, nella costruzione di parcheggi che moltiplicano l’uso delle auto, nella cementificazione dei pochi lembi di terra ancora verdi. Sono le nostre città, insomma, in cui una larga parte dei cittadini crede ancora nella pacifica coesistenza tra vizi privati e pubbliche virtù. In questo panorama, Rebecca attua una resistenza silenziosa, che non nega il dolore, ma lo assume come compagno di vita. Una delle pagine più significative descrive cosa vuol dire, per una bambina, sapersi irrimediabilmente brutta; in essa l’autrice dà forma poetica ai processi di auto-oggettivazione:
“Un bambina brutta vive con prudenza, cercando comportamenti che non aggiungano disturbo a quello che già viene dal proprio aspetto. Una bambina brutta non fa i capricci, non chiede, impara presto a mangiare senza fare briciole con il pane, gioca in silenzio spostando solo il necessario, mette in ordine la propria stanza prima che le venga chiesto, non si fa sorprendere due volte a rosicchiarsi le unghie, non consuma calze e scarpe perché si muove in modo composto, non alza la voce, non fa rumore quando scende le scale, non discute i vestiti da mettere.
Una bambina brutta è grata a tutti per il bene che le vogliono nonostante la delusione per la sua nascita, sta al suo posto, ringrazia per i regali che sono proprio quelli giusti per lei, è sempre felice di una proposta che le viene rivolta, non chiede attenzioni o coccole, si tiene in buona salute, almeno non dà preoccupazioni dal momento che non può dare soddisfazioni.
Una bambina brutta vede, osserva, indaga, ascolta, percepisce, intuisce; in ogni inflessione di voce, espressione del viso, gesto sfuggito al controllo, in ogni silenzio breve o lungo, cerca un indizio che la riguardi, nel bene e nel male. Teme di ascoltare qualcosa che confermi quello che sa già, e cioè che la sua esistenza è una vera disgrazia. Spera di sentire una parola che la assolva, fosse pure di pietà.
Una bambina brutta è figlia del caso, della fatalità, del destino, di uno scherzo della natura. Di certo non è figlia di Dio.”
Il passo descrive le conseguenze dell’interiorizzazione dello sguardo altrui, uno sguardo che sancisce una condanna inappellabile: sei brutta. I processi di auto-oggettivazione sono quei processi che ci spingono a monitorare ossessivamente il nostro aspetto fisico perché lo sguardo oggettivante ci ha fatto interiorizzare la prospettiva dell’osservatore, vale a dire a trattare noi stesse come oggetti da valutare sulla base dell’apparenza. Mediante l’auto-oggettivazione donne e ragazze imparano a pensarsi come oggetti del desiderio altrui. Fare attenzione al modo con cui ci si presenta agli altri, interiorizzare il loro sguardo è per il genere femminile una strategia antica, che illude di controllare le relazioni sociali nella speranza di migliorare la qualità della vita. Se, però, il confronto è perdente, la focalizzazione sull’aspetto induce sentimenti di umiliazione, comportamenti di evitamento, stati di malessere psicologico che possono innescare depressioni e disturbi. Gli studi psicosociali non si sono sufficientemente soffermati sulle conseguenze dei processi di auto-oggettivazione in persone brutte, come Rebecca. Lo stimolo a farlo e alcuni suggerimenti contenuti nel racconto sono doni che la scrittrice fa a tutti noi, perché impariamo a scrutare altri lati di un fenomeno che ci circonda e che rende amara la vita.
[1] Mariapia Veladiano (2011). La vita accanto. Torino: Einaudi.
[2] Sui processi di oggettivazione e auto-oggettivazione si vedano: il quarto capitolo del libro di C. Volpato (2011). Deumanizzazione. Come si legittima la violenza. Roma-Bari: Laterza; C. Volpato (2022). Psicosociologia del maschilismo, Bari-Roma: Laterza, edizione aggiornata; M. G. Pacilli (2014). Quando le persone diventano cose, Bologna, Il Mulino; M. G. Pacilli, E. Cadeddu, F. Spaccatini (2020). Oggettivazione sessuale. Che cos’è e perché fa male (non solo) alle donne, “Minority Reports. Cultural Disability Studies”, 10(1), pp. 59-77.
Autore/i dell'articolo
Blog Kategorien
- Aggressività (12)
- Benessere (1)
- Complottismo (1)
- Covid-19 (16)
- Deumanizzazione (7)
- Disuguaglianza (10)
- Identità (19)
- Omofobia (3)
- pandemia (16)
- Perdono (1)
- Pride (2)
- Psicoterapia (1)
- Salute mentale (1)
- Sincronia (2)
- Violenza (3)
Post popolari del blog
Nuvola di keyword
agency cambiamento sociale cognizione cognizione sociale contatto intergruppi deumanizzazione editoriale infraumanizzazione Mindfulness pregiudizio relazioni interpersonali sessualizzazioneNewsletter
Keep me updated about new In-Mind articles, blog entries and more.