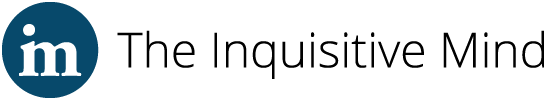28.07.2025 |
Aggressività / Disuguaglianza
La guerra non ha un volto di donna. Svetlana Aleksievič
In questi giorni tremendi, densi di immagini belliche in cui sono uomini coloro che decidono le guerre del mondo e le donne non sembrano avere la possibilità o la capacità di esprimere una logica alternativa, ho letto un libro potente, scritto da Svetlana Aleksievič, di padre bielorusso e madre ucraina, giornalista e scrittrice, premio Nobel per la letteratura nel 2015. La guerra non ha un volto di donna (2015) [1] dà voce, con assoluta assenza di retorica, alle donne che durante la seconda guerra mondiale hanno militato nell’Armata Rossa per difendere la patria invasa dai tedeschi. Siamo abituati a leggere o ascoltare racconti di guerra di voci maschili. Qui emerge una prospettiva differente, originale, quella di donne impegnate in un’occupazione che percepiscono e definiscono disumana, ricordata non in chiave eroica, ma attraverso un’estrema sofferenza, personale, interpersonale, collettiva, che si estende in modo empatico a comprendere il dolore di tutto l’ambiente circostante, natura compresa. Centinaia di migliaia di ragazze, spesso giovanissime, nella maggior parte volontarie, sono andate a combattere come istruttrici sanitarie, tiratrici scelte, fucilieri mitragliatori, a capo di batterie antiaeree o nel genio, accomunate dall’appellativo ‘sorelline’ [2], scoprendo nel conflitto aspetti sconosciuti di sé: “Ma non ci conoscevamo ancora, non sapevamo ancora di essere così forti…”
Secondo Aleksievič le guerra “femminile” è più atroce di quella “maschile” perché le donne non vengono cresciute con l’idea di combattere e quando arrivano al fronte sono impreparate sul piano dei sensi e dei sentimenti; reagiscono in modo diverso dai loro compagni, vedono cose a loro precluse e non conservano gli stessi ricordi. Forse perché per le donne uccidere è più difficile, conclude l’autrice. L’esperienza bellica innesca in loro riflessioni sul non senso della distruttività umana, che scaturiscono da considerazioni sull’ambiente naturale e umano, come quelle di Tamara, che, osservando la distruzione di tanti ponti, si chiede quanti anni saranno necessari per ricostruirli: “La guerra uccide il tempo, il prezioso tempo dell’uomo.”
In guerra le ragazze tentano di preservare attimi di bellezza: “In primavera ti portavi nel ricovero un ramoscello d’arbusto e lo mettevi nell’acqua per farlo durare. Per contemplarlo.” Commoventi e tragici i racconti sulla conclusione del conflitto e sulle speranze per il futuro. “Ne eravamo tutti convinti: Dopo la guerra, dopo quell’oceano di lacrime, la vita non poteva che essere bellissima. Meravigliosa. Dopo la Vittoria… Dopo quel giorno… Gli uomini sarebbero ormai stati solo buoni, si sarebbero voluti bene l’un l’altro. Sarebbero tutti diventati fratelli e sorelle.” E ancora: “Sono arrivata a Berlino. Ho lasciato scritto sul Reichstag: ‘Io, Sof’ja Kuncevic, sono venuta qui per uccidere la guerra.” Un sentimento che collima con quello dall’autrice che, nelle pagine introduttive, afferma di aver voluto scrivere “un libro sulla guerra tale da provocare nel lettore nausea e repulsione per essa, così che già la sola idea della guerra gli diventi odiosa. E ne veda la demenza. Un libro che renda l’idea della guerra nauseante per gli stessi generali.”
Finito il conflitto, le soldate sono tornate a casa e hanno taciuto. Per quarant’anni. Ma quando la scrittrice chiede loro di ricordare, dopo qualche esitazione, tirano fuori tutto il non detto, e piangono. “Mi sono fatta un’idea… sono rimasta in vita per raccontare tutto questo…”, confida Nina, sergente maggiore, istruttrice sanitaria nelle truppe corazzate.
Nel dopoguerra molte si sono ritrovate sole e vulnerabili; passata l’euforia iniziale, è subentrato lo smarrimento; come avrebbero potuto tornare alla vita civile? All’inizio si sono nascoste: “non ci appuntavamo neanche le decorazioni al valore. Gli uomini le portavano, le donne no. Erano gli uomini i vincitori, gli eroi, i buoni partiti, la guerra era stata una cosa loro, noi invece, hanno cominciato a guardarci con occhi diversi. Glielo voglio dire: ci hanno defraudato della vittoria. Dandoci in cambio un’ordinaria tranquillità femminile.” La cosa peggiore è stata sentirsi abbandonate dagli uomini che durante le battaglie le avevano stimate e protette. “Ma le ragazze di allora si sono quasi tutte ritrovate sole. Non si sono sposate. Vivono in appartamenti in coabitazione.” Questo perché i reduci volevano dimenticare e pensavano di essere in questo aiutati da compagne che non avesse visto ciò che loro avevano visto, cercavano ragazze che non avessero conosciuto gli orrori della prima linea. Qualcuna, più fortunata, si è sposata e ha avuto figli: “Volevo una casa e una famiglia. E che la casa odorasse di bambini. Ho annusato e annusato i primi pannolini, non riuscivo a staccarmene. Erano gli odori della felicità. La felicità femminile… In guerra non ci sono odori femminili, sono tutti maschili. La guerra odora di maschio.”
Un sentimento che torna nei racconti è un sentimento poco indagato dagli studi psicosociali: l’odio. Quello provato nel vedere i tedeschi ridere calpestando la terra russa. Quello appreso durante la formazione: “Senza odio non puoi sparare… Se vai a caccia, magari, ma non in guerra. Ai corsi di istruzione politica ci leggevano l’articolo di Il’ja Erenburg intitolato ‘Uccidilo!’ Ogni tedesco che incontri sia un tedesco in meno sulla terra. Un articolo famoso, lo leggevamo tutti, lo imparavamo a memoria.” Quello finalmente dismesso nell’incontro con un prigioniero giovanissimo a cui Natal’ja regala mezza pagnotta: “Ero felice… felice di non potere odiare. E all’epoca ne ero io stessa meravigliata…” La fine dell’odio è subitanea, come racconta un’infermiera che, facendo il giro, si stupisce che un ferito russo si preoccupi del tedesco che gli giace accanto: “Non erano più nemici ma semplicemente due persone ferite distese l’una di fianco all’altra. Accomunate da qualcosa di umano. Ho osservato più di una volta con quale rapidità questo avvenisse…” Il confine tra deumanizzazione e umanizzazione sembra una sottile linea rossa, sulla quale noi psicologi sociali dovremmo riflettere di più.
Aleksievič, S. (2015). La guerra non ha un volto di donna. L'epopea delle donne sovietiche nella Seconda Guerra Mondiale. Milano, Bompiani (ed. orig. 1985).
[2] Il vezzeggiativo "sorellina", sestricka, viene da sestra, "infermiera"
Nascondi i commenti degli utenti
Mostra i commenti degli utenti
Autore/i dell'articolo
Blog Kategorien
- Aggressività (12)
- Benessere (1)
- Complottismo (1)
- Covid-19 (16)
- Deumanizzazione (7)
- Disuguaglianza (10)
- Identità (19)
- Omofobia (3)
- pandemia (16)
- Perdono (1)
- Pride (2)
- Psicoterapia (1)
- Salute mentale (1)
- Sincronia (2)
- Violenza (3)
Post popolari del blog
Nuvola di keyword
agency cambiamento sociale cognizione cognizione sociale contatto intergruppi deumanizzazione editoriale infraumanizzazione Mindfulness pregiudizio relazioni interpersonali sessualizzazioneNewsletter
Keep me updated about new In-Mind articles, blog entries and more.