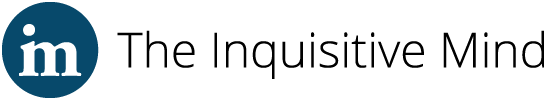07.05.2025 |
Identità
Fuorché il silenzio. Trentasei voci di donne afghane
Fuorché il silenzio[1] riunisce i racconti di trentasei donne afghane di lingua dari, raccolti durante i mesi successivi all’abbandono dell’Afghanistan da parte degli occidentali il 15 agosto 2021 e al concomitante ritorno al potere dei Talebani, considerati dalle scrittrici “la raffigurazione della morte” (Marziya Mohammadi, p.80) e “l’annullamento del futuro” (Anisa Gul Neshat, p.168). Come spiega Zahra Mosavi: “In Occidente… non capiscono o forse non vogliono capire…Non sanno che i talebani hanno la possibilità di condannare a morte il popolo” (p.207). Le testimonianze danno conto delle lotte delle donne afghane di fronte alla rinnovata imposizione di norme che negano loro i diritti più elementari, lotte che nascono da un tragico e realistico sentimento di urgenza: “Forse un giorno non avrei più potuto dire il mio nome da nessuna parte, mi avrebbero chiamata figlia di tizio, sorella di caio o madre del tal dei tali. Dopo qualche anno, avrei dimenticato io stessa il mio nome. Mi sarei trasformata in una palude” (Zahra Karimi, p.187).
I racconti appartengono a quelle che i critici letterari definiscono scritture del sé, nelle quali donne diverse per estrazione sociale, culturale ed economica, si rivelano accomunate dall’assunzione di responsabilità verso le generazioni future, perché non si trovino ad affrontare le terribili situazioni del presente: “In passato le mani delle nostre madri non avevano avuto la possibilità di unirsi una all’altra, ma noi ora potevamo tenerci per mano anche da lontano, potevamo prendere per mano persino le donne di tutto il mondo” (‘Atefe Watanyar, p.365). Affiora costantemente la consapevolezza di far parte di una catena generazionale, motivata dall’impegno verso le più piccole che ancora non sanno quale tragedia si sia abbattuta su di loro: “Negli slogan che urlavamo c’era la voce di tutte le donne, voci che sentivamo provenire dalle oscure profondità della storia… Urlavano, tramite le nostre voci, le donne delle generazioni passate, di quella presente, e di quelle future, era soprattutto il loro destino che avevamo a cuore. Urlavamo il loro dolore di essere donne in un paese chiuso e crudele, urlavamo contro tutte le idee, la mentalità, le condizioni limitanti imposte alle donne nel corso della storia” (‘Atefe Watanyar, p.366).
Sono molti i motivi per leggere questo libro, anche al di là della scoperta della resistenza eroica delle donne afghane che non accettano il ritorno all’oscurantismo religioso e maschilista imposto dai talebani; attraverso il racconto delle loro lotte conosciamo più da vicino la realtà di un paese, ancora intriso di tribalismo e di disprezzo per le minoranze etniche e di genere. Non a caso gran parte delle donne scese in piazza a protestare contro l’insensata violenza talebana appartiene alla minoranza hazara, scita, più aperta nei costumi e relativamente paritaria nei rapporti di genere rispetto alla maggioranza pashtun, sunnita, che ha espresso i talebani. Sono donne che hanno studiato, alcune sono laureate, altre hanno dovuto interrompere gli studi a causa degli editti che hanno vietato l’istruzione femminile, consentendo alle bambine di frequentare la scuola solo fino agli otto anni. Da tutti i racconti emerge l’enorme significato dato allo studio come strumento di emancipazione e liberazione personale e collettiva: “Più studiavo, più immaginavo di studiare anche per le mie sorelle che non avevano potuto farlo e per migliaia di donne di questo paese” (Aziz Gul Afghan-Bik, p.151). E proprio il fatto di aver studiato rende ancora più invise queste donne al potere dominante, rozzo, ignorante, incapace di comprendere il valore dello studio e di accettare che componenti della parte più bassa e umiliata della società si distinguano per capacità intellettuali e competenze professionali.
Leggendo, impariamo a conoscere la difficile vita delle donne afghane circondate da una cultura patriarcale, nella quale nascere femmina è una catastrofe: “Ora tutti aspettano di vedere che figlio metterà al mondo questa sposa: sono io, la prima figlia di questa coppia, io la causa della disperazione della famiglia paterna” (Azita Nazimi, p.468). Le donne sono considerate naqis ul’aql, carenti in intelletto, un’espressione araba che esprime la credenza che le donne siano intellettualmente inferiori agli uomini (Zahra Karimi, p.180). Per la cultura tradizionale afghana, i maschi sono “lo scopo della creazione” e le femmine vengono al mondo “solo per aiutare i maschi. Dopotutto sono state create dalla costola sinistra di Adamo” (Maryam Ebram, p.376). Impera la cultura dell’onore, il namus, strettamente legato al comportamento delle donne e alla risposta degli uomini a offese e oltraggi. In tale contesto il matrimonio combinato resta per le giovani l’unico orizzonte possibile, nonostante i rapporti con la famiglia del marito siano di regola fonte di abusi e soprusi.
Impariamo anche a conoscere il “pensiero talebano” che “ha radici profonde nella nostra terra, radici che vanno fatte seccare, o nessuna donna nella sua vita vedrà mai giorni felici, qui” (Aziza Shafi’i, p.292). Un pensiero costruito sull’assenza di pietà e “fede nella violenza” (Lina Ahmadi, p.37), che considera “le donne solo dei mezzi di riproduzione o schiave sessuali, esseri che devono restare a casa a servizio degli uomini” (Maryam Ebram, p.389). Emerge più volte nei testi la collusione tra afghani e talebani, che “rappresentano l’essenza del pensiero degli uomini afghani” (Zarafshan Sharifi, p.453). Una collusione che determina l’assenza maschile nelle lotte e rende i talebani sempre più spietati, fino a determinare esiti disperanti: “La battaglia delle donne assomiglia ora a delle urla sott’acqua. Nessuno le sente e se qualcuno le sente, non risponde” (Sabira Akbari, p.358).
La cosa che più colpisce nella lettura è la fortissima e incondizionata adesione delle testimoni all’identità sociale femminile, che rivendica un’indiscussa superiorità sulla controparte maschile. Le donne sono consapevoli del proprio valore, sanno di costituire “la parte più progressista di questa generazione. Sono coloro che aprono la strada alle proteste e alla lotta, educando le prossime generazioni a difendere i propri diritti” (Nastaran Nastoh, p.242). La superiorità rivendicata è intellettuale, ma soprattutto morale: “Ora, non era degno di noi donne esprimere il nostro odio davanti al loro odio; al contempo non potevamo sottometterci; considerato che i talebani avevano il potere di reprimerci e che si sentivano legittimati a farlo dalla loro fede e dalle loro credenze, mentre noi donne eravamo civili, costruttrici di cultura, in possesso di un pensiero di pace che coltivasse la pace” (Maryam Ebram, p.390). E ancora: “Questa forse è la ragione che sostiene le rivolte femminili di questo paese. Una delle cose di cui ho ferma certezza è che nessuna donna abbia in alcun modo preso parte a quei massacri, alle distruzioni e ai saccheggi. Al contrario, sono loro che hanno impedito ai propri mariti di prendere parte a quelle gesta criminali, che hanno spinto i loro giovani figli e i propri fratelli ad astenersi dalla guerra e a essere tolleranti verso i nemici imprigionati. Nessuna donna avrebbe mai detto a un uomo della propria famiglia: “Vai, uccidi, ruba e distruggi”” perché “le donne sono costruttrici e creatrici” (Shima Sediqi, pp.98-99). In molti racconti affiora l’importanza della trasmissione femminile nella costruzione della coscienza civile, come ad esempio nello scritto di Shima Sediqi, che ricorda quanto imparato da Turpikai Qandahari: “Da lei appresi che per creare un Afghanistan migliore era necessario investire di più sulle donne. Se la parte maschile della famiglia aveva imparato dalla società il principio della vendetta, le donne potevano ripulire la loro mente e al posto della vendetta insegnare l’affetto: il rancore è legato alla distruzione, mentre la bontà corrisponde alla costruzione e allo sviluppo” (p.102).
[1] Fuorché il silenzio. Trentasei voci di donne afghane. Testi raccolti da Zainab Entezar, rivisti da Asef Soltanzadeh. Edizione italiana curata da Daniela Meneghini. Milano: Jouvence, 2024.
Nascondi i commenti degli utenti
Mostra i commenti degli utenti
Autore/i dell'articolo
Blog Kategorien
- Aggressività (12)
- Benessere (1)
- Covid-19 (16)
- Deumanizzazione (7)
- Disuguaglianza (10)
- Identità (19)
- Omofobia (3)
- pandemia (16)
- Perdono (1)
- Pride (2)
- Psicoterapia (1)
- Salute mentale (1)
- Sincronia (2)
- Violenza (3)
Post popolari del blog
Nuvola di keyword
agency cambiamento sociale cognizione cognizione sociale contatto intergruppi deumanizzazione editoriale infraumanizzazione Mindfulness pregiudizio relazioni interpersonali sessualizzazioneNewsletter
Keep me updated about new In-Mind articles, blog entries and more.