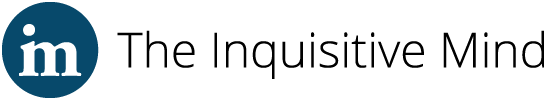Stereotipi di genere e disturbi alimentari
La diagnosi nella popolazione maschile: una realtà sottostimata
Perché, quindi, i DNA sono rimasti dominio di una psicopatologia tutta al femminile per secoli?
Uno dei motivi è sicuramente rintracciabile negli studi epidemiologici, che sottolineano una loro maggior prevalenza nella popolazione femminile con un rapporto tra i generi che si aggira attorno a 1:4 (Sweeting, 2015), con variazioni piuttosto consistenti a seconda del disturbo: da 1:3 a 1:10 per l’anoressia, da 1:3 a 1:12 per la bulimia, da 1:2 a 1:6 per il disturbo d’ alimentazione incontrollata (Darcy et al., 2011; Hudson et al. 2007). Se questa maggior prevalenza nel genere femminile è incontrovertibile, è altrettanto incontrovertibile che quella nella popolazione maschile abbia visto una rapida crescita negli ultimi anni (Ricciardelli, 2015) e sia destinata ad aumentare ulteriormente (Smink et al., 2012; Udo et al., 2018). Ciò è evidente specialmente se si considera la popolazione adolescente: all’interno di essa i tassi di prevalenza tra i generi risultano sempre più vicini, specialmente per quanto riguarda i disturbi dell’immagine corporea e i comportamenti alimentari disfunzionali non riconducibili a una specifica categoria diagnostica (Ackard et al., 2007; Strigel-Moore et al., 2009), come i DANAS/EDNOS o i DAAS/OSFED (si veda il glossario).
Inoltre, si evince in modo altrettanto evidente che i dati inerenti alla popolazione maschile potrebbero essere notevolmente sottostimati in virtù della minor propensione, motivata da stereotipi culturali e di genere, a riconoscere all’interno della suddetta popolazione problematiche inerenti all’alimentazione e alle forme corporee (Faravelli et al., 2006; Murray et al., 2017).
Questo è vero anche in riferimento agli strumenti e ai manuali diagnostici, a lungo costruiti sulla base dell’applicabilità alla sola popolazione femminile, alcuni dei quali considerano come necessari segni e sintomi il cui verificarsi nel genere maschile è biologicamente impossibile - come la sopracitata amenorrea - o diversamente interpretabile in base al genere - come l’Indice di Massa Corporeo (IMC, calcolabile secondo la formula (peso (kg))/(altezza^2 (mt))). Se infatti è vero che nel DSM-5 il criterio diagnostico relativo all’amenorrea è stato eliminato, è altrettanto vero che l’IMC è rimasto l’unico criterio preso in considerazione per valutare la gravità del disturbo anoressico, senza tenere in considerazione la differente morfologia del corpo maschile e di quello femminile. Ed è evidente come, a parità di IMC, una persona di genere maschile e una di genere femminile possano presentare stati psicofisici e di malnutrizione molto differenti tra loro, in virtù delle differenze genere-specifiche (Ricciardelli, 2015).
Ciò si configura come una questione di importanza cruciale, se si pensa che, nella gran parte delle strutture pubbliche dedicate al trattamento dei DNA, l’IMC è considerato come uno dei fattori principali nella valutazione della presa in carico e del relativo progetto di cura (De Virgilio et al., 2012).
La malpractice clinica: una popolazione in esilio
La mancata considerazione di queste specificità ha portato a rilevanti criticità nella pratica diagnostica e nell’implementazione di strategie efficaci e mirate da un punto di vista terapeutico: sottostimare casi con disturbi gravi, non rilevare manifestazioni subcliniche comunque associate a livelli significativi di compromissione o addirittura alla formulazione di diagnosi differenziali errate, come è spesso accaduto con la diagnosi di depressione (Jones et al., 2010). Nell’ambito del trattamento, quindi, solo di recente si è giunti alla strutturazione di piani d’intervento pensati tenendo conto delle manifestazioni genere-specifiche della sintomatologia (Darcy et al., 2011). Per molti anni numerose strutture residenziali e semiresidenziali dedicate al trattamento di queste patologie non hanno previsto la potenziale presa in carico di pazienti di genere maschile, in quanto la domanda non veniva percepita come un’urgenza sanitaria tale da motivare un ripensamento delle strutture o un investimento per adeguare il contesto sanitario alla loro accoglienza (Dalla Ragione et al., 2009; Murray et al., 2017). Ancora oggi, alcune di queste strutture hanno difficoltà a prendere in carico soggetti di genere maschile e/o non presentano protocolli d’intervento mirati che non si basino su prototipi sintomatologici femminili (Hoek et al., 2003; Murray et al., 2017). Questo ha contribuito al consolidarsi dello stigma legato all’essere un uomo con sintomi alimentari (Darcy et al, 2011; Harvey et al, 2003), che, a sua volta, contribuisce alla minore capacità, sia da parte del soggetto sia da parte dellɜ professionistɜ della salute mentale con cui entra in contatto, di riconoscere questi sintomi e quindi indirizzare l’individuo verso trattamenti adeguati (Jones et al., 2010).
Un ulteriore fattore culturale legato agli stereotipi di genere (si veda il glossario) concorre alla diagnosi inefficace dei DNA nella popolazione maschile: la comprovata maggior prevalenza di tale categoria di disturbi tra le minoranze sessuali (si veda il glossario) e il conseguente timore di vedere ipotizzata una presunta omosessualità, nei soggetti affetti da DNA che si rivolgono ai contesti di cura.
Spieghiamoci meglio.
Autore/i dell'articolo
Articolo in pdf
Newsletter
Keep me updated about new In-Mind articles, blog entries and more.