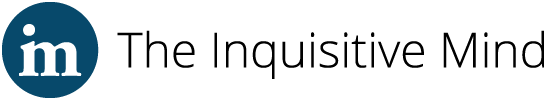La sfida dell’essere genitori: affrontare le pressioni sociali mantenendo uno stile educativo funzionale
Di fronte a questi cambiamenti, è quindi fondamentale che i genitori adottino strategie flessibili e coerenti con le esigenze in continua evoluzione dei loro figli adolescenti. Alcune di queste strategie possono essere, ad esempio, incentivare e mantenere una comunicazione aperta e basata sull’ascolto attivo e il reciproco rispetto; supportare l’adolescente anche nei momenti di difficoltà e fallimento; seguire il percorso di crescita del figlio senza invadere i suoi spazi ma offrendo supporto quando necessario.
Le pressioni socioeconomiche: l'impatto sulle pratiche genitoriali
L’iperprotezione definisce una serie di comportamenti genitoriali per lo più inappropriati dal punto di vista dello sviluppo dei figli e, per tale ragione, è stata studiata in relazione al periodo adolescenziale, momento in cui gli adolescenti sentono il bisogno di imparare a gestire i doveri e affrontare gli ostacoli in modo più autonomo. È rilevante capire meglio le possibili ragioni che spingono i genitori a mettere in atto questo tipo di condotta, poiché le ricerche passate hanno mostrato esiti negativi di questo comportamento genitoriale in relazione al periodo adolescenziale. L'ambiente sociale e alcune esperienze vissute dai genitori stessi contribuiscono a determinare l’adozione di specifiche strategie genitoriali (Costa et al., 2020; Grolnick, 2003). I genitori appaiono spesso inclini ad adottare una maggiore protezione o controllo nei confronti dei figli, soprattutto se percepiscono delle possibili fonti di pericolo o difficoltà (Wang et al., 2023). Da questo punto di vista, elementi legati alla sfera sociale o economica possono divenire fattori di rischio per l’attuazione di una genitorialità maggiormente protettiva. La società spesso, attraverso pubblicità, social o comuni mass media, detta gli standard di una genitorialità ideale, basata sulla priorità assoluta dei bisogni dei figli e su un impegno di tempo significativo nella loro educazione (Nomaguchi & Milkie, 2017). La letteratura mostra che le società occidentali hanno standard molto elevati per la buona genitorialità. I genitori possono rispondere in modo diverso a questi standard sociali e questa variabilità può avere un impatto sulle modalità in cui gestiscono i propri figli, determinando pratiche genitoriali diverse da cultura a cultura (Lamprianidou et al., 2025). Questi standard quando percepiti come elevati, possono creare nei genitori il timore di non essere adeguati e la sensazione di dover soddisfare aspettative elevate. Questa dinamica che prende il nome di “perfezionismo genitoriale” può portare a comportamenti eccessivamente protettivi e a difficoltà nel bilanciare un adeguato coinvolgimento genitoriale con l'autonomia necessaria ai figli, soprattutto durante l'adolescenza (Kawamoto & Furutani, 2018; Lee et al., 2024).
Autore/i dell'articolo
Articolo in pdf
Newsletter
Keep me updated about new In-Mind articles, blog entries and more.