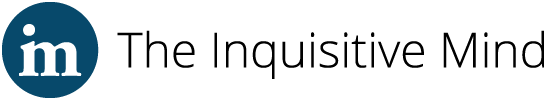L’uso delle neuroimmagini nello studio della mente: è tutto oro quel che luccica?
L’avanzamento tecnologico del mondo contemporaneo ha permesso di applicare allo studio della mente alcune metodiche d’indagine che sarebbero apparse fantascientifiche solo pochi decenni fa. Tra queste metodiche vi è sicuramente la “risonanza magnetica” ed in questo articolo cerco di mettere in luce alcuni elementi che possano far comprendere qual è lo stato attuale della ricerca scientifica in quest’ambito. Innanzitutto, la risonanza magnetica è una metodica che permette di visualizzare il cervello in vivo. Questa semplice espressione, in vivo, porta in sé una rivoluzione che ha determinato un impressionante salto qualitativo rispetto ai metodi disponibili nella neurologia classica, come ad esempio il metodo di correlazione anatomo-funzionale post-mortem. Questo consisteva nell’attendere, una volta classificato un dato paziente in termini di deficit cognitivo, anni e forse decenni per eseguire un esame cerebrale post-mortem, così da poter mettere in relazione (correlare appunto) quella determinata disfunzione con una specifica area o insieme di area risultate danneggiate dall’esame post-mortem. Sebbene tale approccio abbia contribuito a chiarire alcuni meccanismi fondamentali del funzionamento cerebrale, appaiono subito anche evidenti ovvie limitazioni, legate principalmente al tempo intercorso tra la rilevazione del deficit e l’esame post-mortem, che ovviamente poteva portare all’insorgenza di altri deficit e fattori tali da rendere assai più complessa l’interpretazione della relazione anatomo-funzionale.
Non c’è quindi da stupirsi se la possibilità di esaminare un cervello in vivo, e cioè appena rilevato il deficit e senza la necessità di attendere un esame post-mortem, abbia portato ad un significativo incremento delle nostre conoscenze sul funzionamento cerebrale. Oltre a permettere una dettagliata visualizzazione di eventuali lesioni e danni cerebrali (risonanza magnetica “strutturale”) queste tecnologie permettono anche di comprendere il funzionamento del cervello (risonanza magnetica “funzionale”), misurando la cosiddetta attività emodinamica cerebrale durante lo svolgimento di un compito cognitivo. È bene sapere che l’attività emodinamica consiste in una misura indiretta del funzionamento cerebrale (Mangia et al., 2009): nel momento in cui un determinato insieme di cellule cerebrali diviene più attivo perché coinvolto nell’esecuzione di un compito, così come un atleta durante lo svolgimento di una competizione, necessita maggiori risorse ed in particolare maggiore apporto di ossigeno e di zuccheri (glucosio). Ossigeno e zuccheri vengono trasportati nel flusso ematico, che aumenterà selettivamente proprio in corrispondenza di quelle aree cerebrali costituite dalle cellule attive durante quel dato compito cognitivo. Per alcune aree del cervello si assiste quindi ad un incremento selettivo di attività emodinamica ed è proprio questo che viene rilevato dalla risonanza magnetica funzionale (Sacco, 2013). Tramite questa tecnologia è stato possibile assistere negli ultimi due decenni ad un rapido sviluppo delle cosiddette neuroscienze cognitive, il cui obiettivo è appunto quello di comprendere i correlati neurali dei molti processi mentali e cognitivi, e cioè l’area o l’insieme di aree cerebrali coinvolte nel processo. Questo non vuol dire, tuttavia, che il funzionamento cerebrale sia stato del tutto compreso, anzi. I ricercatori che operano in questo campo sono ben coscienti di quanto ci sia ancora da scoprire e di quanto ciascun approccio e metodica sperimentale, per quanto tecnologicamente avanzata, porti con sé anche dei limiti dei quali bisogna esser ben coscienti.
A volte invece, quando assistiamo alla divulgazione su articoli di giornale di risultati scientifici ottenuti tramite metodiche di neuroimmagini – strutturali o funzionali che siano – ci troviamo di fronte a delle descrizioni poco dettagliate e soprattutto poco critiche rispetto al come quei risultati sono stati ottenuti. Le conseguenze di questo sono ben esemplificate da uno studio che mostra come tipicamente i risultati scientifici accompagnati da “neuroimmagini” (e cioè immagini cerebrali) siano ritenute più affidabili. McCabe & Castel (2008) hanno chiesto ad un ampio numero di soggetti (studenti universitari) di valutare la credibilità e l’affidabilità di alcuni risultati scientifici che potevano essere accompagnati da un semplice grafico a barre, da neuroimmagini con attivazioni cerebrali, o da nessuna immagine. I risultati di questo studio mostrano valutazioni significativamente più alta in termini di valore scientifico quando i risultati erano accompagnati da neuroimmagini, mostrando una sorta di effetto di “neurorealismo” (Sacco, 2013). McCabe & Castel interpretano la fascinazione data dalle neuroimmagini come il risultato della presentazione di una base fisica e concreta che porta ad una spiegazione riduzionistica (e quindi semplificata) del processo cognitivo, che è per sua natura invece un fenomeno “astratto” e di difficile comprensione.
Lo studio di McCabe & Castel (2008) fa comprendere quanto le neuroimmagini possano far presa sull’immaginario collettivo. Proprio per questo è necessario essere cauti nelle conclusioni a cui si pensa di giungere con tale metodica e consapevoli dei limiti attuali in cui ci muove. Nel presente articolo cerco di mettere in luce tre importanti limitazioni che si tende a non considerare quando si riportano i risultati derivanti da studi di neuroimmagini, così da favorire auspicabilmente la qualità della divulgazione scientifica. Tali limitazioni riguardano l’uso del cosiddetto “modello generale lineare”, i limiti intrinseci di ciò che viene definito come “approccio sottrattivo”, e non ultimo il fatto che la messa in relazione tra area e processo mentale non equivale ad un vincolo causale.
Autore/i dell'articolo
Parole chiave dell'articolo
Newsletter
Keep me updated about new In-Mind articles, blog entries and more.